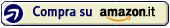I frutti tropicali rappresentano l’esotico che arriva in tavola con i suoi colori sgargianti, i profumi e il potere di seduzione tipico dei paesi da cui provengono.
Succosi, aromatici e decisamente stuzzicanti, sia per gli occhi che per il palato, questi frutti hanno anche diverse proprietà benefiche e un notevole valore nutrizionale che li rende ancora più appetibili.
Introdurre il consumo abituale di frutti tropicali nella dieta quotidiana è sicuramente un ottimo modo per tenersi in forma. Meglio ancora, se si sceglie frutta esotica coltivabile anche in Italia che non deve essere necessariamente importata dagli angoli più remoti del Pianeta.
E quale migliore occasione dell’estate per fare un bel carico di vitamine e benessere? Ecco una guida pratica dedicata all’esplorazione del variopinto mondo della frutta esotica.

Coloratissimi e curiosi: i frutti esotici hanno un fascino davvero unico!
Frutti tropicali: cosa sono e da dove vengono
Mango, papaya, cocco, frutto della passione, ananas, litchi e tanti altri ancora. L’elenco della frutta tropicale facilmente reperibile anche dalle nostre parti è davvero infinito. Si tratta di alimenti salutari e benefici per l’organismo, oltre che estremamente versatili in cucina. Si possono utilizzare per arricchire, macedonie, preparare frullati, primi piatti esotici e dolci originali.
In generale, si tratta di alimenti ricchissimi di nutrienti essenziali, come sali minerali e vitamine. Perfetti per fare il pieno di benessere sopratutto quando il caldo torrido o i malanni stagionali mettono a dura prova le difese immunitarie dell’organismo.
Per conoscere l’universo che compone la grande varietà dei frutti esotici e delle piante tropicali da cui essi derivano, è opportuno tracciare una prima distinzione in base al sapore della frutta. In linea di massima, la frutta esotica dolce o acidula ha proprietà e caratteristiche organolettiche simili alla frutta nostrana, mentre quella “grassa” è più assimilabile alla frutta secca o ai semi oleosi.
In quest’ultimo caso, infatti, l’apporto calorico è notevole e la presenza di grassi di tipo insaturo in grandi concentrazioni li rende difficilmente assimilabili alla frutta genericamente intesa. Pensiamo all’avocado, ad esempio, così ricco di acidi grassi buoni, vitamine e beta-carotene: 100 grammi di questo alimento apportano ben 160 calorie!
I principali paesi produttori dove questa frutta è considerata “autoctona” sono concentrati nel Tropico del cancro (da cui il nome “tropicale”). I maggiori produttori sono Stati del Continente Africano e in America Latina, ma anche India, Indonesia e nei Paesi in Via di Sviluppo. Vista la grande richiesta di frutta esotica sul mercato occidentale, di recente l‘Onu ha messo in atto una serie di iniziative volte ad incentivare l’adozione di tecniche di agricoltura biologica della frutta esotica nel Sud del Mondo per incrementare la qualità dei cibi e tutelare la sicurezza alimentare.
Proprietà dei frutti tropicali
A seconda del frutto e delle caratteristiche organolettiche che lo distinguono, il consumo di frutta esotica promuove importanti azioni benefiche nell’organismo. Si tratta di alimenti generalmente ricchi di fibre, sali minerali, vitamine e acidi grassi, concentrati in quantità significative.
Tutti sappiamo, ad esempio, che le banane sono una preziosa fonte di potassio, mentre l’ananas è un concentrato naturale di vitamina C ed A dalle innumerevoli proprietà benefiche. I frutti tropicali aciduli o dolci presentano notevoli quantità di:
- Acqua
- Carboidrati solubili
- Fibre
- Vitamine idrosolubili e liposolubili (in particolare la vitamina C o acido ascorbico C, Vitamina A e carotenoidi;
- Sali Minerali, in particolare potassio e magnesio
- Fenoli e tannini
- Fitosteroli
Quelli grassi, invece, aggiungono un alto contenuto lipidico e proteico, da cui deriva il maggior apporto calorico a parità di porzione consumata. Al loro interno, inoltre, sono presenti nutrienti generalmente poco presenti nella frutta “tradizionale”, come calcio, selenio, tocoferolo e Vitamina E.
Frutti tropicali: elenco e nomi
Tra i frutti tropicali più consumati nel nostro Paese e nell’emisfero occidentale del Mondo, ce ne sono alcuni che occupano da tempo un posto d’onore nella nostra cultura alimentare. Altri invece sono più costosi e particolari, considerati”di nicchia, e altri ancora poco conosciuti e a dir poco curiosi. Ecco una carrellata coloratissima di questi frutti.
Frutti tropicali di largo consumo

Tante proprietà e benefici suggeriscono un consumo regolare di questi frutti
Frutti tropicali “di nicchia”
Frutti tropicali “ricercati”
- Kumquat
- Mangostano
- Cherimoya
- Feijoa
- Frutto della Passione o Maracuja
- Durian
- Guava
- Pitaya o Dragon fruit
- Granadilla
- Salak
- Graviola
- Tomatillo
- Lucuma
- Curuba
- Jackfruit
- Longkong
- Sapote
Frutti tropicali coltivabili in Italia
L’Italia ha aperto ormai le porte non solo all’importazione della frutta esotica, ma anche alla coltivazione di molte varietà che possono adattarsi e prosperate in tante regioni della Penisola. La Sicilia, in particolare, ma anche diverse aree del Sud Italia, è la regione che sta sperimentando con sempre maggiore convinzione la coltivazione di piante ed alberi tropicali fruttiferi.
Il mercato è florido e i prezzi decisamente più competitivi rispetto ai prodotti analoghi di importazione, con tagli sul prezzo finale che sfiorano il 50%. La frutta tropicale coltivata con più successo in lungo e in largo dello Stivale include diverse varietà di:
- Avocado
- Papaya
- Annona Cherimola
- Feijoa
- Maracuja
- Ananas
- Banano
- Mango
- Carambola
- Guava
- varietà nane di Pipino dolce e Tomarillo
Frutti tropicali rossi
Il rappresentante forse più bizzarro della frutta esotica rossa è senza dubbio il Litchi, detto anche “ciliegia della Cina” per via del suo aspetto che ricorda vagamente quello delle comuni ciliegie nostrane.
I frutti delle varietà più comuni hanno una buccia ruvida di colore rosa-rosso e una polpa bianca. La polpa è anche è l’unica parte commestibile del frutto ed è caratterizzata da un sapore delicato e naturalmente dolce.
Il litchi contiene sali minerali, proteine, vitamine del gruppo B e C, acido nicotico, fibre, carboidrati, zuccheri e acqua. Il suo apporto calorico è tutto sommato modesto: 66 calorie ogni 100 grammi.
Frutti tropicali arancioni
Sempre molto vasta, la schiera dei frutti tropicali arancioni. Uno su tutti è l’alchechengi, protagonista dell’autunno e di molte scenografiche composizioni rese speciali dalle sue bacche particolari. I suoi frutti autunnali dal colore arancio vivo che maturano sulla pianta protetti da un involucro di consistenza cartacea al tatto la cui forma ricorda una piccola lanterna.
Per via delle spiccate proprietà e benefici, è una pianta officinale molto usata in erboristeria. Esercita infatti un’azione diuretica, depurativa, lassativa, antireumatica e tonificante.
Frutti tropicali gialli
Oltre la banana, tra la frutta esotica di colore giallo c’è anche la Papaya, ricchissima di enzimi proteolitici, tra cui spicca la papaina, che favorisce oi processi digestivi. La papaya ha anche elevate quantità di vitamina C, caroteni e provitamina A, nutrienti indispensabili per mantenere in salute il tratto urinario, i polmoni, l’apparato digerente e il derma.
La pianta è originaria delle zone tropicali americane, ed è caratterizzata dalle foglie grandi e dai frutti a forma di bacca oblunga. Il colore della buccia può essere verde – giallastro, mentre la polpa è di colore giallo-arancione, dolce e succosa.
Frutti tropicali rosa
Rosa e particolarissimo come la pitaya, detta anche dragon fruit. Questo frutto è prodotto da una varietà di cactus (Hilocereus) coltivata soprattutto in Sud America e Vietnam. Si caratterizza per i grandi fiori bianchi che si aprono di notte e durano solo un giorno.
Esistono alcune varianti di colore rosso o giallo, ma la varietà più diffusa è quella rosa a polpa bianca di origine vietnamita. La polpa contiene minuscoli semi neri commestibili e ha un gusto dolce, delicato e rinfrescante. Tra i frutti tropicali, il dragon fruit è sicuramente uno di quelli che si fa più notare…
E voi, che ne dite? Scriveteci nei commenti le vostre osservazioni (e i vostri frutti tropicali preferiti!)
Leggi anche:
- Mangostano, proprietà e utilizzi
- Rambutan, un curioso frutto tropicale
- Achacha, un frutto simile al melone
- Chayote proprietà e ricette