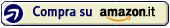L’abaca è una fibra di origine naturale di origini asiatiche sempre più utilizzata dall’industria tessile ed esportata in tutto il Mondo.
Molto spesso, infatti, sulle etichette di tanti indumenti, borse e oggetti di uso comune compare la dicitura “Musa Textilis” o più semplicemente la sigla “AB” (Abaca) che indica, appunto, la pianta di canapa da cui si ottiene questo resistentissimo tessuto 100% naturale.
Come detto, nel linguaggio comune, l’Abaca o Abacà è conosciuta come Canapa di Manila, di Cebu, di Davao. Tuttavia, pochi sanno che in realtà, questo arbusto, non ha nulla a che vedere con la Canapa propriamente detta.
In effetti, la pianta dell’Abaca appartiene alla famiglia delle Musaceae ed è strettamente imparentata con il Banano da frutto. Non a caso, nel lessico botanico, il banano prende il nome di “Musa Paradisiaca”. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su una delle più straordinarie fibre naturali ottenibili dalla lavorazione delle piante e sulle sue caratteristiche distintive.
Abaca pianta
La pianta dell’Abaca è un arbusto di medio-grandi dimensioni originario delle Filippine e appartenente alla famiglia botanica delle Musaceae, la stessa da cui deriva il banano da frutto e tante altre piante tropicali dell’Africa e dell’Asia.
Come il banano e il platano, dunque, anche la Abaca è una Musa. In realtà, si tratta più precisamente di una grossa pianta erbacea che può svilupparsi fino a 5-6 metri di altezza. Si caratterizza per un falso tronco grosso e massiccio che non è ligneo, ma prodotto dalla stratificazione di numerose foglie sovrapposte di grandi dimensioni. Anche fiori e frutti ricordano molto il banano, ma il loro valore nutritivo è decisamente inferiore.
Dalla lavorazione delle guaine che avvolgono il fusto fiorale e quello sotterraneo (perenne), si ottiene una delle più apprezzate e utilizzate fibre naturali tessili, al pari della fibra di bambù, del cotone, della Rafia e del Rattan.
Per far ciò, si procede ad una sorta di vendemmia che consiste nella “sguainatura” praticata due o tre volte l’anno sulle piante più giovani. Successivamente, si procede con la “spampanatura” e solo alla fine all’essiccazione al sole delle fibre ottenute da questa lavorazione.

Coltivazione di Canapa di Manila
Abaca: materiale e tessuto
Olandesi e Inglesi, tra il 1925 e il 1930, furono i primi ad introdurre l’Abaca in Europa. Tuttavia, è degli Americani il merito di aver avviato le prime, grandi coltivazioni di Canapa di Manila a fini industriali.
Prima di allora, le fibre di Abaca erano già ampiamente utilizzate sia come tessuto che come materiale da cordame. Le popolazioni del sud-est asiatico utilizzano ancora oggi questa forte fibra per realizzare imbragature, reti, corde, spaghi, gomene, e altro materiale da pesca. Il motivo è che la fibra dell’Abaca è talmente resistente e duratura da non temere neanche l’usura dell’acqua salata.
Oltre a questi oggetti, dalla lavorazione dell’Abaca si ricava anche una poltiglia utilizzata per produrre carte speciali, come la carta moneta, filtri e bustine da tè e tisane. Molti prodotti di artigianato locale, ad esempio i tappetti fatti a mano, cappelli e borse di pregio sono confezionati ancora oggi con questa fibra e con antiche tecniche artigianali.
Canapa di Manila
Curiosamente, l’Abaca non ha nulla a che fare con la pianta della Canapa, né tanto meno con la famiglia botanica delle Cannabaceae. Eppure i suoi primi scopritori la scambiarono per un arbusto appartenente a queste varietà, forse fuorviati dall’uso analogo che ne videro fare alle popolazioni locali.
Il nome “Canapa di Manila“, infatti, è ispirato alla capitale filippina che è ancora oggi una delle principali produttrici di questa fibra, assieme ad alcune regioni dell’isola di Sumatra e del Borneo.
Musa Textilis
Come ormai sappiamo, il nome botanico dell’Abaca è Musa Textilis, attribuitole nel 1801. Alcuni ritengono che il termine ricordi Antonio Musa, medico e botanico che visse nel I secolo Avanti Cristo sotto il regno dell’imperatore Augusto.
L’etimologia della parola, senza dubbio, è strettamente connessa alla famiglia delle Musaceae che include piante monocotiledoni dell’ordine Zingiberales. Più precisamente il nome “Musa” deriverebbe dall’arabo “moz” o “moza”, latinizzato successivamente in Musa.

Forte e resistente, la fibra di Abaca non teme nessun agente atmosferico e l’acqua del mare.
Dalla sua lavorazione, oggi si ottengono tessuti morbidi, ecologici, a basso costo che danno vita ad indumenti comodi da indossare e molto duraturi. Peculiarità che accomunano l’Abaca a tante nuove fibre vegetali destinate all’abbigliamento naturale e ad arredi per la casa di origine vegetale.
Ma non è tutto. Questa fibra naturale è molto apprezzata anche dall’industria fashion. In tal senso, l’Abaca è utilizzata sopratutto per la creazione di spettacolari cappelli che spesso vediamo indossare agli aristocratici Britannici.
Ciò che è ancora più importante è che dietro ogni foglia di Abaca non c’è solo una storia, una lavorazione unica, un modo di vivere e delle tradizioni millenarie.
Gli agricoltori e le comunità locali dei paesi produttori fondano buona parte della loro economia sulla lavorazione di questa eccellente materia prima. Ciò significa che deve essere tutelata e avviata ad uno sviluppo equo e solidale al pari di tante altri prodotti “esotici” molto richiesti dal mondo occidentale.
Leggi anche
- Rattan, una fibra naturale elegante ed economica per arredare con gusto
- Giunco una fibra naturale insolita per arredi in stile coloniale
- Scopriamo i mobili in cartone, eco-sostenibili ma anche belli e resistenti
- Scopriamo la fibra di eucalipto